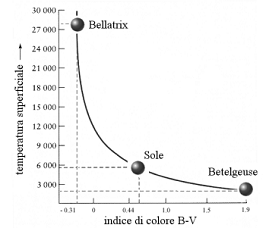|
|
|
|
|
|
|
|
|
I colori delle stelle
Claudio
Elidoro
|
La necessità di ottenere
misurazioni oggettive e affidabili sul colore delle stelle spinse nel 1953
gli astronomi H.L. Johnson
e W.W. Morgan a ideare un
sistema di filtri da collocare davanti al rilevatore della luminosità delle
stelle. Questi filtri lasciavano passare solamente la luce la cui lunghezza
d’onda era compresa entro un preciso intervallo di valori. Il dato raccolto
dallo strumento, dunque, permetteva di determinare oggettivamente se
nell’intervallo di lunghezze d’onda permesse dal filtro una stella fosse più o meno luminosa di un’altra. I filtri introdotti da Johnson e Morgan erano caratterizzati dai seguenti valori (le
lunghezze d’onda sono espresse in Ångström):
Il valore della lunghezza d’onda centrale, caratteristica di ogni filtro,
ci permette di vedere che il filtro U si colloca nella regione
dell’ultravioletto, il B nel blu e il V nella regione giallo-verde, con una
risposta abbastanza vicina alla risposta dell’occhio umano. Ma l’uso dei filtri si mostra molto utile anche quando viene applicato ad una singola stella. Le differenze tra
la sua magnitudine rilevata con un filtro e quella raccolta con un altro
vengono indicate con le sigle B-V e U-B e ad esse ci si riferisce con il
termine di indici di colore. L’indice di colore ci offre notevoli informazioni, molto di più della
semplice rilevazione della magnitudine. Se una stella ha un indice B-V
positivo significa che la sua emissione nel visibile è maggiore di quella nel
blu (ricordiamo che le magnitudini diventano più piccole all’aumentare della
luminosità) e dunque la stella apparirà più rossa. Viceversa un indice B-V
negativo sarà il segno distintivo di una stella che emette nella regione blu
dello spettro elettromagnetico. Un paio di esempi numerici possono chiarire meglio il concetto. Le magnitudini apparenti di Spica usando i
filtri B e V sono, rispettivamente, 0,7 e 0,9. Questo comporta che l’indice
di colore B-V risulta essere: (B-V)Spica =
0,7 – 0,9 = – 0,2 Un analogo calcolo per Antares (B = 2,7 e V =
0,9) ci consente di ottenere (B-V)Antares =
2,7 – 0,9 = 1,8 Risultati che confermano che la superficie di Antares
è molto più fredda di quella di Spica.
Nella fig. 2 vengono messe a confronto con il Sole due stelle della
costellazione di Orione, l’azzurra Bellatrix (g Orionis) di tipo spettrale B2 e la rossa Betelgeuse
(a Orionis) di tipo
spettrale M2. Il grafico intende descrivere il legame tra l’indice di colore
e la temperatura solo in modo approssimato. Cameron
Reed (The Journal of the Astronomical
Society of Canada, vol 92 n.1
pag. 36) fornisce agli amanti delle formule un paio di espressioni che legano
l’indice di colore alla temperatura:
Per chi si accontenta di molto meno, nella tabella 2 sono riportati i
valori degli indici di colore, del tipo spettrale e della magnitudine visuale
di alcune stelle abbastanza conosciute. Per ciascuna stella, inoltre, viene
indicata anche la temperatura superficiale (in °K)
dedotta dall’indice di colore. Tabella 2
Inizialmente, Vega era stata scelta come
stella campione per definire la magnitudine Le informazioni fornite dall’indice di colore, però, non si limitano
solamente a suggerire il valore della temperatura superficiale. Incrociati
con altri parametri ci permettono di spingere la nostra conoscenza delle
stelle a livelli inaspettati. Ma racchiudere nelle poche righe che ci restano l’analisi dei
diagrammi colore-luminosità sarebbe davvero troppo riduttivo. Sarà dunque
materiale per una successiva spigolatura. |