














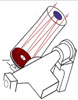

Con il telescopio da 60 cm erano condotti studi su ogni genere di oggetti celesti: dalle comete alle stelle variabili, dalle supernovae agli ammassi, dalle galassie alle nebulose. Questa intensa attività di ricerca e l’analisi dei risultati ottenuti suggeriva continue e nuove ricerche, spingendo l’Istituto di Astronomia di Bologna a contatti sempre più stretti con analoghe istituzioni in Italia e all’estero.
Nel 1970 fu istituito presso l’Università degli Studi di Bologna anche il Corso di Laurea in Astronomia, già presente presso l'Università di Padova.
Nello stesso periodo, le nuove problematiche di ricerca e la necessità di amministrare una didattica sempre più qualificata spinsero l’Università a potenziare le strutture della stazione osservativa di Loiano, in modo da renderla competitiva con i maggiori complessi astrofisici europei del tempo.
Il primo atto che diede l’avvio alla realizzazione del nuovo telescopio può essere fatto risalire al 15 marzo 1968: in quella data, il Direttore dell’Istituto di Astronomia inviò alla Facoltà di Scienze una richiesta di sviluppo della stazione astronomica di Loiano. La nuova stazione di osservazione fu edificata a pochi metri dalla preesistente, con la piena disponibilità del sig. Mezzini, allora sindaco di Loiano, e dell’intera Amministrazione Comunale.
Progettato e costruito dalla ditta francese REOSC, il telescopio ha la struttura tipica dei moderni telescopi: è assente il tubo e le parti ottiche sono sostenute da un traliccio metallico. Una serie di contrappesi bilanciano lo strumento, in modo da renderlo agile e preciso nei puntamenti.
Il sistema ottico è costituito dallo specchio principale da 152 cm di diametro, dotato di un foro centrale, e da uno specchio secondario del diametro di circa 60 cm. Lo specchio principale riceve la luce direttamente dall’oggetto osservato e la riflette sul secondario, posto frontalmente a circa 4 m, che a sua volta la fa convergere in corrispondenza del foro centrale, dietro al quale si trovano gli strumenti che registrano e analizzano la luce raccolta. In questo modo in una struttura di 5 m di lunghezza è ospitata un’ottica di 12 m di sviluppo focale, con una notevole diminuzione di costi e ingombri. Il sistema ottico prende il nome da Ritchey e Chrétien, che per primi lo idearono.
L’edificio è stato progettato dalla Sezione Tecnica dell’Università di Bologna, che ha anche esercitato la direzione lavori. La cupola è opera della Ditta CO.ME.VA. di Vicenza su progetto REOSC.
I primi lavori per la costruzione dell’edificio iniziarono nella primavera-estate del 1974. La struttura è divisa in tre piani, adibiti a differenti usi.
Al pianterreno vi è un’ampia sala, alta circa 4,5 m, destinata alle operazioni di carico e scarico dello specchio.
Al primo piano si sviluppano diverse sale: una camera oscura, un studio-soggiorno, la stanza di controllo del telescopio e il centro di calcolo. Al secondo piano, dotato di un ampio pavimento mobile che facilita le osservazioni, è ospitato il telescopio.
Il telescopio stesso è sostenuto da due pilastri con fondazioni indipendenti e privi di punti di contatto con l’edificio: questo serve a evitare che le vibrazioni prodotte dai movimenti della cupola e del pavimento mobile si trasmettano al telescopio, disturbandone le osservazioni.