





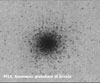







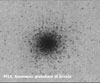





A Bologna l’astronomia era insegnata fin dal XII secolo. Ebbe famosi docenti, tra questi Domenico Maria Novara, amico e insegnante di Niccolò Copernico, e Gian Domenico Cassini. All’inizio del Settecento, il conte Luigi Ferdinando Marsili si rivolse ad Eustachio Manfredi per la costruzione della Specola e per l'organizzazione delle ricerche astronomiche. Con la fondazione dell'Istituto dell'Accademia delle Scienze fu progettata, nel 1712, la torre sovra cui dovevasi stabilire la Specula.
Per tutto il XVIII secolo, la Specola bolognese godette di grande considerazione in tutto il mondo. Nel Settecento, l’ultimo importante contributo bolognese all'astronomia venne dall'abate Giovan Battista Guglielmini, che dimostrò la rotazione della Terra mediante la caduta dei gravi e misurando la loro deviazione dalla verticale all’interno della torre della Specola e della torre degli Asinelli.
Negli anni Trenta del secolo scorso lo sviluppo della città e il conseguente aumento delle luci notturne spinse l’Università a realizzare un nuovo osservatorio a Loiano. Negli anni Settanta, per assicurare a Loiano un'attività osservativa adeguata allo sviluppo delle tecnologie e alle problematiche moderne fu realizzato il telescopio da 152 cm. All’inizio degli anni Ottanta quello che sino allora era stato l’Istituto di Astronomia divenne il Dipartimento di Astronomia con lo scopo di promuovere la ricerca e la didattica della astronomia, e contemporaneamente, sfruttando la legge di riforma degli Osservatori, nacque anche a Bologna l’Osservatorio Astronomico con il compito di promuovere la ricerca astronomica. Dall’inizio dell’attuale secolo l’Osservatorio è confluito nell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF).
Gian Domenico Cassini occupa un posto rilevante nella storia dell’astronomia per i grandi contributi dati allo sviluppo sia strumentale, che osservativo e teorico di questa disciplina. Gian Domenico Cassini nacque in Liguria, a Perinaldo, nel 1625.
Nel 1649, per aver previsto la vittoria delle truppe di Innocenzo X, adunate a Bologna per una spedizione militare contro il Duca di Parma, acquisì notorietà di astrologo, cosa che egli assolutamente non era e non volle mai essere.
Venne, comunque, chiamato a Bologna dal marchese Malvasia ad occuparsi del suo osservatorio privato e l'anno successivo ottenne l'insegnamento universitario di Astronomia. L'importanza delle ricerche svolte a Bologna lo rese uno dei più noti astronomi europei dell'epoca e, per questo, nel 1669 venne chiamato a Parigi dal Re Sole, Luigi XIV, presso l'Observatoire Royale, appena istituito.
A Parigi Cassini si sposò e dette origine ad una vera e propria dinastia di astronomi che diressero l'Observatoire sino alla rivoluzione francese, con il pronipote Cassini IV.
La realizzazione per la quale Cassini va giustamente ricordato è la grande meridiana di San Petronio, realizzata all'interno della chiesa bolognese nel 1655. Si tratta della più lunga linea meridiana al mondo: ben 66,8m, pari esattamente alla seicento millesima parte della circonferenza terrestre.
Nel 1925 fu donata all'Osservatorio la cospicua somma di trecentomila lire per acquistare un grande telescopio. Guido Horn d'Arturo, allora direttore dell’Osservatorio, iniziò la trattativa con la ditta Karl Zeiss di Jena per la costruzione di un telescopio riflettore da 60 cm di diametro, di ottima qualità. Lo strumento arrivò a Bologna nel luglio 1933, racchiuso in nove casse del peso complessivo di 60 quintali.
Nel frattempo l'amministrazione universitaria aveva acquistato due ettari di terreno sul monte Orzale presso Loiano, a circa 40 km da Bologna.
Il 15 novembre 1936 fu inaugurata la nuova stazione osservativa e il 21 dicembre dello stesso anno fu effettuata la prima fotografia con il nuovo telescopio.
Negli anni Sessanta dello scorso secolo il telescopio da 60 cm diventò inadeguato per una ricerca competitiva a livello internazionale per cui si cominciò a pensare alla realizzazione di un nuovo e più potente telescopio.
Ancora oggi lo strumento mantiene intatti gli aspetti tecnici e edilizi dell'epoca in cui fu costruito. Il rivestimento di legno della cupola, il rumore degli ingranaggi del movimento, i bilanciamenti dello strumento, le scale utilizzate per l'osservazione colpiscono le persone che si rendono consapevoli di essere alla presenza oltre che di uno strumento scientifico anche di una testimonianza del nostro patrimonio industriale.
Guido Horn (1879 – 1967) nacque a Trieste, a quel tempo governata dall'impero austro-ungarico, da una famiglia ebrea. Sentendosi italiano, durante la prima guerra mondiale egli aggiunse il cognome paterno "d'Arturo" al proprio e disertò l’esercito austriaco per arruolarsi volontario in quello italiano.
A partire dagli anni Trenta progettò un nuovo genere di telescopi, sostituendo al tradizionale specchio monolitico uno "specchio a tasselli". Nonostante le innumerevoli difficoltà finanziarie, l’astronomo triestino riuscì a realizzare uno strumento con lo specchio principale da 180 cm di diametro e 10,40 m di lunghezza focale, costituito da un mosaico di specchi esagonali. Oggi questo specchio è esposto nel Museo della Specola.
Il telescopio a tasselli di Horn d’Arturo è considerato il precursore di moderni strumenti, quali i Keck Telescope e l’Hobby - Eberly Telescope.
L’avventura bolognese di Horn d’Arturo si interrupe durante il periodo della guerra, quando la follia razzista lo cacciò dall’Osservatorio a causa delle sue origini ebraiche. Solo nel dopoguerra fu reintegrato nell’incarico e poté tornare nella sua casa, all'interno dello stesso Osservatorio.
Convinto che le conoscenze astronomiche dovessero essere il più possibile rese note, nel 1931 Horn d'Arturo fondò Coelum, la prima rivista italiana per la divulgazione dell’astronomia. Per la qualità degli articoli la testata raggiunse, in pochi anni, una vasta popolarità.