|
Telescopi ed Osservatorii del 2000 |

|
Telescopio Gemini Nord (Mauna Kea- Hawaii)
Grandi occhi sul cielo
Nell'ultima decade del XX secolo l'uomo ha posto mano alla costruzione
di grandi, grandissimi telescopi. Essi costituiscono autentiche meraviglie nel campo
dell'ottica, dell'ingegneria, della meccanica e dell'elettronica.
Ognuno racchiude in sè migliaia di anni-uomo lavoro: molto
impegno infatti deve essere profuso per fare di un grande progetto un ottimo
telescopio, un prezioso strumento, che per alcuni decenni sia in grado
di marcare le frontiere della scienza.
Sempre più grandi?
La dimensione di un telescopio si indica con il diametro del suo specchio primario.
Il concetto di grande dipende dall'epoca: negli anni 80,
a parte il 5 metri del Palomar, grande significava
un diametro di 3.5 - 4 metri, mentre, nell'anno 2000, grande significa almeno 8 metri. Un bel salto davvero!
Si costruiscono grandi telescopi per allargare la pupilla: più grande
infatti è lo specchio, maggiore risulta l'energia raccolta, a parità delle
altre condizioni. Si possono quindi rivelare oggetti di bassissima luminosità,
solitamente molto lontani e quindi osservare situazioni molto vecchie.
Studiare le loro caratteristiche,
significa capire come era l'universo in quella lontana epoca.
Come sono gestiti?
La costruzione di un grande telescopio comporta grandi impegni
progettuali, economici ed organizzativi. Per tale motivo essi sono
spesso il frutto
di complesse collaborazioni internazionali. Per esempio il Progetto Gemini
si basa su di una collaborazione tra Stati Uniti, Gran Bretagna,
Canada, Cile, Australia, Argentina e Brasile.
A volte la collaborazione riguarda anche la costruzione della strumentazione accessoria
del telescopio. Questo aspetto nel tempo ha visto accrescere la sua importanza:
gli strumenti sono ormai estremamente complessi dal punto di vista meccanico, ottico
ed elettronico e spesso presentano vari modi di funzionamento tra loro alternativi e complementari. Essi richiedono lunghi tempi di progettazione e sviluppo e finanziamenti cospicui.
Quanto costano?
Nella costruzione di un grande telescopio si devono sostenere costi molto alti in tutte le varie
fasi di sviluppo. La progettazione, spesso lunga e complessa comporta un lavoro
coordianto da parte di ingegneri strutturali, meccanici, ottici ed elettronici.
Lunga e delicata
è poi la fase di fusione dello specchio e della sua sucessiva lavorazione ottica.
Non vanno neppure sottovalutati i costi del trasporto di questi mastodontici specchi nei loro
imballaggi dalle officine ottiche sino al loro sito definitivo, spesso collocato sulla
vetta di una montagna alta 4000 mila metri. La Fondazione W.M. Keck per costruire i due
meravigliosi gemelli da 10 metri di diametro ha sostenuto tra il 1989 ed il 1996 una spesa
superiore ai 140 milioni di dollari. Una grossa cifra invero, che forse
tuttavia non sarebbe sufficiente ad una squadra corse per partecipare ad un paio di
campionati di formula 1.
 Montature
Montature
Gli specchi dei grandi telescopi hanno diametri di 8 o più metri ed anche se sono
estremamente sottili, il loro peso risulta considrevole. Prendendo come esempio un telescopio
del Very Large Telescope dell'ESO, esso ha un primario con le seguenti caratteristiche:
- diametro: 8200 mm
- spessore: 177 mm
- peso: 23000 Kg
Ne consegue che la struttura destinata a sostenerlo debba essere particolarmente robusta
e stabile. La montatura di un telescopio, che offre i maggiori requisiti di rigidità,
è quella altazimutale (
descritta nella sezione strumenti).
Essa risulta anche la meno costosa e la più compatta; l'unico problema che essa comporta
è che, per poter inseguire una sorgente nel suo moto, il telescopio deve muoversi
contemporaneamente attorno ai suoi due assi di rotazione. Un movimento combinato, che dipende
dalla latitudine dell'osservatorio e dalle coordinate della sorgente. Ciò tuttavia
non rappresenta un problema al giorno d'oggi, con i motori ed i sensori di posizione
asserviti ad un'elettronica gestita da un computer. Il posizionamento del telecopio viene
effettuato con la precisione del centesimo di secondo d'arco.
[Nella foto il quarto telescopio del VLT, UT4 (Unit Telescope 4) durante una fase di
assemblaggio nelle officine dell'Ansaldo (Milano, Italia)]
Fuochi
Nei grandi telescopi dell'ultima generazione continuano ad essere utilizzati sia il
classico fuoco Cassegrain, per la seplicità d'uso e la
rapidità,
sia il fuoco Coudè, destinato agli strumenti di ingombro maggiore oppure
quando occorra estrarre il fascio focale per farlo confluire assieme ad altri altri in
un unico rivelatore. Tali configurazioni sono disponibili quando si disponga di più
telescopi in grado di operare in modo combinato (Keck, VLT).
Rispetto al passato ha perso di importanza il fuoco primario, estrmamente rapido, ma di complessa
attivazione. Ciò lo si deve al fatto che l'esigenza di un fuoco tanto rapido è oggi
meno sentita, dal momento che sono disponibili rivelatori di immagini a stato solido, CCD,
talmente sensibili ed efficienti, da poter operare con tempi di integrazione ridottissimi
anche se montati su fuochi meno rapidi.

Per i nuovi telescopi ha assunto grande importanza il fuoco
Nasmyth, tipico delle montature altazimutali. Tale fuoco è sistemato in corrispondenza
dell'attacco dell'asse orizzontale del telescopio con la forcella della montatura e viene
attivato con un'estrazione laterale del fascio ottico mediante uno specchio a 45 gradi.
Il grande vantaggio è che il fuoco giace in coincidenza del punto di appoggio
del telescopio sulla montatura altazimutale, facilmente accessibile, ove possono
essere sistemati strumenti, anche di grosse dimensioni, che non determinano alcun aumento della
massa in movimento del telescopio. L'unico problema consiste nel fatto che il campo di vista
del telescopio al fuoco Nasmyth ruota attorno all'asse orizzonle del telescopio, mentre
questo si muove per il normale inseguimento della sorgente. Occorre quindi accoppiare
gli strumenti mediante un derotatore, che è di per sè un'interfaccia
meccanica complessa.
[Nella foto il derotatore al fuoco Nasmyth
dell' UT1 del VLT - ESO]
 Ottiche attive
Ottiche attive
Specchi sottili come quelli del VLT dell'ESO, con uno spessore pari a solo
i 2% del diametro, al di fuori delle possibilità tecniche solo di
qualche anno fa, consentono certamente di diminuire in modo sostanziale il
peso e quindi di rendere tutta la struttura meccanica più leggera, ma
rendono lo specchio poco rigido e quindi sensibile ad ogni perturbazione,
termica o meccanica che sia. D'altra parte l'elasticità della struttura
consente di poterne controllare con un apposito sistema la forma, in modo
da farle assumere quella desiderata. L'applicazione di tali concetti
ha portato alla definizione delle ottiche attive per i telescopi.
In pratica un sistema elettronico automatico agisce sul fondo posteriore
dello specchio mediante numerosi attuatori, 150 nel caso del VLT, modificandone la forma ottica al
fine di ottimizzare il fronte d'onda proveniente dalla sorgente. Appena il
fronte d'onda cambia, il sistema riassesta lo specchio in modo ottimale.
Le perturbazioni che si riescono ad eliminare sono quelle a variazione temporale
lenta, da qualche decina di secondi, fino ad un massimo di un secondo,
tipicamente quelle termiche e meccaniche.
Per rimuovere le perturbazioni ottiche con frequenza maggiore, bisogna ricorrere ad
un tipo di sistema differente:
l'
ottica adattiva.
Ottiche adattive
L'ottica adattiva è costituita d aun sistema ottico-meccanico ingrado di rilevare le
perturbazioni del fronte d'onda ad alta frequenza, sino a qualche decina di hertz, che
si originano nell'alta atmosfera e che vanno sotto il nome di seeing.

La rimoszione delle distorsioni viene effettuata su di un piccolo specchio posto sul
cammino del fascio ottico, la cui forma è controllata da un sistema analogo
a quello delle ottiche attive. L'esame del fronte d'onda viene svolto
con frequenza superiore al decimo di secondo, osservando una sorgente naturale
(stella) od artificiale (stella laser), generata da un laser ottico al sodio, collimato
con il fascio del telescopio e focalizzato nella mesosfera, a 90 Km di altezza. Ivi
è presente un sottile strato di sodio atomico che riflette il fascio laser e
produce l'immagine di una stella con m
V=10.
La foto a fianco ben illustra il risultato dell'intervento del sistema di ottica
adattiva montato al Telescopio Keck II.
Nella foto è mostrato un campo stellare in direzione del centro galattico.
I quadratini in basso mostrano la visione del campo del telescopio con il
sistema per l'ottica adattiva non in funzione (a sinistra) ed in funzione
(a destra). Il miglioramento della risoluzione angolare risulta
davvero sorprendente: si passa dal secondo d'arco al centesimo di secondo d'arco, operando nel vicino infrarosso !!
Strumentazione
La strumentazione accessoria di un grande telescopio non rappresenta affatto un aspetto di
secondaria importanza, ma un punto di qualificazione importante per un osservatorio
astronomico nell'attuale scenario di alta competizione internazionale.
Risulta difficoltoso
analizzare le potenzialità dei diversi strumenti operanti presso i più
moderni telescopi, senza entrare nei dettagli tecnici, per i quali rimandiamo alla
documentazione scientifica. Qui ci basta osservare che gli strumenti odierni sono
estremamente complessi non solo nella costruzione ottico e meccanica, ma soprattutto nelle
varie funzionalità che presentano. Essendo montati su grossi telescopi ed essendo
essi stessi di grandi dimensioni, non risulta operazione semplice la loro sostituzione.
Da questo punto di vista il fatto di poter operare con differenti funzionalità,
tra loro complementari, risulta non solo un vantaggio, ma spesso un requisito essenziale.
Vi sono strumenti così ingombranti e delicati, che vengono montati in modo permanente
di solito ad uno dei fuochi Nasmyth di un telescopio. Vi sono pertanto spettrografi che
operano dall'ultravioletto all'infrarosso senza soluzione di continuità, altri
che possono con semplicità fornire anche ottime prestazioni come camera ad immagini,
altri ancora che consentono di ottenere spettri singoli di decine di sorgenti contemporaneamente.
Ma la lista potrebbe anche essere molto lunga.
Descriviamo ora brevemente alcuni di questi strumenti
- Keck HIRES (High Resolution Echelle Spectrograph)
- HIRES costituisce lo strumento più grande e complesso (80 quintali di peso,
svariati metri cubi di volume) montato al telescopio Keck I. Realizzato presso il Lick
Observatory, Università di California, da Steve Voght in 5 anni di lavoro e costato
una cifra superiore agli 8 miliardi di lire, HIRES rappresenta lo spettrografo di migliori
prestazioni oggi esistente. Mediante un complesso sistema di filtri e lenti HIRES analizza
la luce delle sorgenti su di un intervallo spettrale che va da 0.3 a 1.1 micron, suddividendola
in migliaia di canali, che vengono registrati su di un CCD di 2048x2048 pixel.
Le prestazioni risultano eccezionali: si possono analizzare sorgenti da 10 a 100 volte
più deboli che con qualunque altro strumento oggi in funzione.
-
Keck LRIS (Low Resolution Imaging Spectrograph)
-
 Il LRIS è uno spettrografo a bassa risoluzione con possibilità
di ottenere immagini dirette su di un CCD di 2048x2048 pixel
con un campo di 6x8 minuti d'arco. Esso è
stato progettato e realizzato da J. Cohen e B. Oke (Caltech) e consiste di
un enorme cilindro del diametro di circa 180 centimetri del peso di 10 quintali.
Particolarmente adatto per l'analisi di oggetti deboli, viene comunemente
utilizzato nello studio di popolazioni stellari in galassie lontane,
nuclei galattici attivi, ammassi di galassie e quasars, nonchè per
deboli sorgenti stellari, nane bianche e brune.
Con esso sono stati misurati i redshift di varie galassie all'interno
dell' Hubble Deep Field, l'immagine più profonda mai ottenuta
ad un telescopio e mostrata nella foto a fianco.
Il LRIS è uno spettrografo a bassa risoluzione con possibilità
di ottenere immagini dirette su di un CCD di 2048x2048 pixel
con un campo di 6x8 minuti d'arco. Esso è
stato progettato e realizzato da J. Cohen e B. Oke (Caltech) e consiste di
un enorme cilindro del diametro di circa 180 centimetri del peso di 10 quintali.
Particolarmente adatto per l'analisi di oggetti deboli, viene comunemente
utilizzato nello studio di popolazioni stellari in galassie lontane,
nuclei galattici attivi, ammassi di galassie e quasars, nonchè per
deboli sorgenti stellari, nane bianche e brune.
Con esso sono stati misurati i redshift di varie galassie all'interno
dell' Hubble Deep Field, l'immagine più profonda mai ottenuta
ad un telescopio e mostrata nella foto a fianco.
Dove si trovano?
Nella costruzione di un grande telescopio il primo e forse più arduo problema da risolvere
è quello del sito. I costi e gli sforzi che si sostengono per la costruzione
impongono la scelta di un luogo con caratteristiche tali da garantire un alto numero di notti
serene, con buon seeing, con condizioni adatte anche alle osservazioni nell'infrarosso,
considerato che tutti i grandi telescopi sono progettati per operare anche in questa banda
dello spettro elettromagnetico.
Una scelta oculata determina infatti le prestazioni finali
del complesso telescopio-strumentazione.
Chiunque abbia anche solo posto l'occhio ad un binocolo astronomico sa bene quale sia il
problema fondamentale da risolvere: trovare un posto buio, molto buio.
Decine di chilometri di lontananza dai
centri abitati non sono spesso sufficienti a garantire condizioni di buio adeguate; inoltre
occorre prevedere che la situazione non subisca sostanziali mutamenti per qualche decennio.
Secondo importante elemento da considerare è la qualità del seeing, che si origina
dalle turbolenze presenti nell'alta atmosfera. Ciò porta a scegliere zone ove insistono
per la maggior parte del tempo condizioni meteorologiche anticicloniche, tipiche delle regioni
desertiche. Tali fattori determinano un buon sito per le osservazioni ottiche, ma non sono
sufficienti per quelle infrarosse, Qui il fattore discriminante è dato dall'umidità
dell'aria, in grado di chiudere, anche completamente, le finestre presenti nella banda
infrarossa. Un buon sito per osservazioni infrarosse deve essere sempre molto secco, con
un quantità di vapor d'acqua precipitabile inferiore al millimetro (altezza della
colonna di vapor d'acqua condensato lungo la linea di vista osservatore-sorgente).
D'altra parte, poichè il vapor d'acqua tende a stratificarsi nella bassa atmosfera,
il fattore determinante diviene l'altezza del sito. In una regione con clima molto secco,
una montagna alta almeno 2500 metri rappresenta un buon sito per le osservazioni infrarosse.
Il miglior sito astronomico, già individuato negli anni 80, è la cima di
un vulcano, Mauna Kea, nell'isola di Hawaii dell'omonimo arcipelago, alta oltre 4000 metri.
Qui v'è la più alta concentrazione di telescopi del mondo: 4 moderni
strumenti di oltre 8 metri si trovano sulla cima del vulcano (Keck I, Keck II, Subaru
e Gemini Nord).

Altri ottimi siti sono costituiti dalla vetta di alcune montagne della Cordigliera delle
Ande, uno dei quali è il Cerro Paranal, ove ha sede il Very Large Telescope dell'ESO.

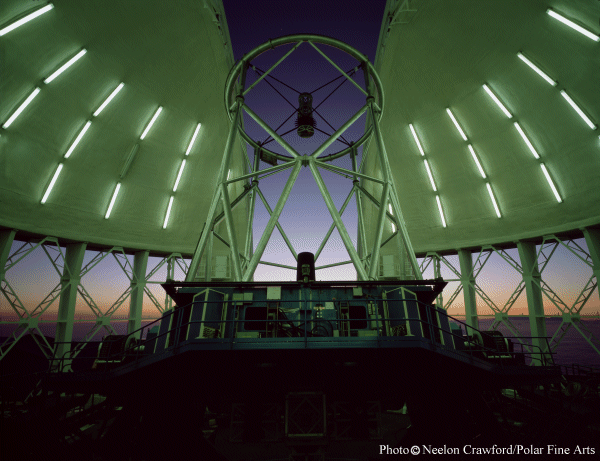
 Montature
Montature Per i nuovi telescopi ha assunto grande importanza il fuoco
Nasmyth, tipico delle montature altazimutali. Tale fuoco è sistemato in corrispondenza
dell'attacco dell'asse orizzontale del telescopio con la forcella della montatura e viene
attivato con un'estrazione laterale del fascio ottico mediante uno specchio a 45 gradi.
Il grande vantaggio è che il fuoco giace in coincidenza del punto di appoggio
del telescopio sulla montatura altazimutale, facilmente accessibile, ove possono
essere sistemati strumenti, anche di grosse dimensioni, che non determinano alcun aumento della
massa in movimento del telescopio. L'unico problema consiste nel fatto che il campo di vista
del telescopio al fuoco Nasmyth ruota attorno all'asse orizzonle del telescopio, mentre
questo si muove per il normale inseguimento della sorgente. Occorre quindi accoppiare
gli strumenti mediante un derotatore, che è di per sè un'interfaccia
meccanica complessa.
Per i nuovi telescopi ha assunto grande importanza il fuoco
Nasmyth, tipico delle montature altazimutali. Tale fuoco è sistemato in corrispondenza
dell'attacco dell'asse orizzontale del telescopio con la forcella della montatura e viene
attivato con un'estrazione laterale del fascio ottico mediante uno specchio a 45 gradi.
Il grande vantaggio è che il fuoco giace in coincidenza del punto di appoggio
del telescopio sulla montatura altazimutale, facilmente accessibile, ove possono
essere sistemati strumenti, anche di grosse dimensioni, che non determinano alcun aumento della
massa in movimento del telescopio. L'unico problema consiste nel fatto che il campo di vista
del telescopio al fuoco Nasmyth ruota attorno all'asse orizzonle del telescopio, mentre
questo si muove per il normale inseguimento della sorgente. Occorre quindi accoppiare
gli strumenti mediante un derotatore, che è di per sè un'interfaccia
meccanica complessa. Ottiche attive
Ottiche attive La rimoszione delle distorsioni viene effettuata su di un piccolo specchio posto sul
cammino del fascio ottico, la cui forma è controllata da un sistema analogo
a quello delle ottiche attive. L'esame del fronte d'onda viene svolto
con frequenza superiore al decimo di secondo, osservando una sorgente naturale
(stella) od artificiale (stella laser), generata da un laser ottico al sodio, collimato
con il fascio del telescopio e focalizzato nella mesosfera, a 90 Km di altezza. Ivi
è presente un sottile strato di sodio atomico che riflette il fascio laser e
produce l'immagine di una stella con mV=10.
La rimoszione delle distorsioni viene effettuata su di un piccolo specchio posto sul
cammino del fascio ottico, la cui forma è controllata da un sistema analogo
a quello delle ottiche attive. L'esame del fronte d'onda viene svolto
con frequenza superiore al decimo di secondo, osservando una sorgente naturale
(stella) od artificiale (stella laser), generata da un laser ottico al sodio, collimato
con il fascio del telescopio e focalizzato nella mesosfera, a 90 Km di altezza. Ivi
è presente un sottile strato di sodio atomico che riflette il fascio laser e
produce l'immagine di una stella con mV=10.  Il LRIS è uno spettrografo a bassa risoluzione con possibilità
di ottenere immagini dirette su di un CCD di 2048x2048 pixel
con un campo di 6x8 minuti d'arco. Esso è
stato progettato e realizzato da J. Cohen e B. Oke (Caltech) e consiste di
un enorme cilindro del diametro di circa 180 centimetri del peso di 10 quintali.
Particolarmente adatto per l'analisi di oggetti deboli, viene comunemente
utilizzato nello studio di popolazioni stellari in galassie lontane,
nuclei galattici attivi, ammassi di galassie e quasars, nonchè per
deboli sorgenti stellari, nane bianche e brune.
Con esso sono stati misurati i redshift di varie galassie all'interno
dell' Hubble Deep Field, l'immagine più profonda mai ottenuta
ad un telescopio e mostrata nella foto a fianco.
Il LRIS è uno spettrografo a bassa risoluzione con possibilità
di ottenere immagini dirette su di un CCD di 2048x2048 pixel
con un campo di 6x8 minuti d'arco. Esso è
stato progettato e realizzato da J. Cohen e B. Oke (Caltech) e consiste di
un enorme cilindro del diametro di circa 180 centimetri del peso di 10 quintali.
Particolarmente adatto per l'analisi di oggetti deboli, viene comunemente
utilizzato nello studio di popolazioni stellari in galassie lontane,
nuclei galattici attivi, ammassi di galassie e quasars, nonchè per
deboli sorgenti stellari, nane bianche e brune.
Con esso sono stati misurati i redshift di varie galassie all'interno
dell' Hubble Deep Field, l'immagine più profonda mai ottenuta
ad un telescopio e mostrata nella foto a fianco.

