
Fabrizio Bònoli e Daniela Piliarvu
Dipartimento di Astronomia dell'Università degli Studi di
Bologna

La presenza nell'area bolognese di conoscenze astronomiche si può far risalire a quel vasto movimento, tra l'VIII ed il IX secolo, che va sotto il nome di "rinascita carolingia". All'interno di questo movimento assumeva grande significato la riforma della Chiesa franca - poi estesa da Carlo Magno a tutti i suoi domini, Bologna compresa, ovviamente - e l’importanza che all’interno di quella riforma veniva data all’istruzione di monaci e chierici. Sono, infatti, di poco successivi a questo periodo i più antichi documenti noti che attestano, nella città di Bologna, la diffusione di conoscenze astronomiche che permettevano di "computare" le date delle feste mobili e di redigere un calendario, anche se con metodi rudimentali. Il codice I-27 conservato nella Biblioteca Antoniana di Padova, ed il codice Angelica 123, della Biblioteca Angelica di Roma riportano dei calendari, rispettivamente, dall'anno 802 al 1063 e dal 1039 al 1120, insieme alle date dei riposi festivi osservati in città e ad alcuni trattati astronomici, matematici e di computo. L'analisi della parte astronomica presente in questi manoscritti permette di risalire alle conoscenze diffuse e alla parte di astronomia che veniva insegnata nell'area bolognese nei secoli intorno al Mille; nel periodo, cioè, in cui si venivano a gettare le basi per il sorgere della collegialità di studiosi, insegnanti e studenti, che darà origine, nella seconda metà dell'XI secolo, a quella Universitas Studiorum che è considerata la più antica università del mondo occidentale.
L'insegnamento dell'Astronomia a Bologna, quindi, risale praticamente alle origini della storia dell'Università, anche se il primo Lettore di Astronomia presso lo Studio bolognese del quale si abbiano notizie certe è Bartolomeo da Parma, il cui insegnamento risulta documentato da un manoscritto delle lezioni tenute agli studenti nel 1297.
Durante i settecento anni che intercorrono da questa data ad oggi, l'astronomia bolognese e, di conseguenza, anche l'insegnamento di tale disciplina hanno conosciuto periodi di splendore alternati a periodi meno brillanti. Avvenimenti talora legati a particolari situazioni locali, talora dovuti ad evoluzioni o rallentamenti nel processo storico dell'astronomia occidentale, talora provocati da sviluppi complessivi delle discipline scientifiche in generale. Si è ritenuto, pertanto, interessante esaminare lo sviluppo dell'astronomia partendo proprio dalla ricostruzione storica del suo insegnamento nell'ambito universitario locale e dalla comprensione di come questo fosse legato o meno al progredire della disciplina nel suo complesso. Punto di partenza per questo lavoro - del quale vengono qui sommariamente presentati i primi risultati - è stato il redigere un elenco ragionato di tutti i docenti di Astronomia, che da un lato potesse servire di base per ulteriori studi e approfondimenti e dall'altro potesse offrire una prospettiva schematica dell'itinerario seguito dalle vicende astronomiche a Bologna, città che è stata anche centro rilevante, non solo nazionale, del panorama astronomico e scientifico.
L'approccio seguito nella prima fase è stato, quindi, di tipo biografico. Per redigere un elenco il più possibile completo di tutti i Lettori di Astronomia dello Studio, sono state utilizzate le fonti che indicano gli ordinamenti di carattere generale dell'Università e riportano l'elenco dei professori incaricati alla lettura delle rispettive materie: i Rotuli dei Lettori, compilati per gli anni dal 1370 al 1799, i Quartironi di pagamento dei salari ai professori, i Registri dei Matricolati, i Diari ecclesiastici della città di Bologna, gli Almanacchi del Dipartimento del Reno fino ai contemporanei Annuari (Tabella 1). Tuttavia, tali fonti si sono spesso rivelate lacunose o in contraddizione fra di loro. Si è, quindi, reso necessario effettuare un attento controllo e un preciso confronto delle varie fonti documentarie.
_______________________________________________________________________
Tabella 1
FONTI UTILIZZATE PER LA COMPILAZIONE DELL’ELENCO DEI LETTORI
Dal trecento al settecento:
Successivamente è stato tracciato il profilo personalizzato di
ogni Lettore; le singole biografie, per un totale di 135, sono state redatte
in ordine cronologico, seguendo uno schema che consentisse di avere un
facile e veloce mezzo di consultazione per chi volesse in seguito affrontare
ulteriori approfondimenti (Tabella 2).
_______________________________________________________________________
Tabella 2
Nella seconda sezione di ogni biografia sono citate le fonti primarie,
cioè le pubblicazioni originali dell'autore ed è inserita
la bibliografia secondaria riguardante ogni docente. Per i docenti più
noti e più prolifici dal punto di vista delle opere pubblicate,
sono state riportate le fonti bibliografiche contenenti l'elenco completo
della loro produzione.
Va, ovviamente, notato che, accanto ad alcune figure di spicco nell'ambito
dell'astronomia non solo bolognese - come Egnazio Danti, Bonaventura Cavalieri,
Gian Domenico Cassini ed Eustachio Manfredi - sono esistiti molti personaggi
minori che si sarebbero limitati all'insegnamento, talora esercitato per
un periodo molto breve, senza apparentemente lasciare un segno particolare
nella storia della disciplina. Per quanto è stato possibile, si
è cercato di stendere una biografia anche dei Lettori meno noti,
la quale, inserita accanto ai nomi dei maggiori astronomi, li inquadrasse
in un contesto più generale, facendo così trovare loro un
posto nel ricordo storico collettivo.
A livello preliminare, si possono fornire alcuni esempi, in varie epoche storiche, di come possono essere utilizzate queste biografie per esaminare i rapporti esistenti tra l'insegnamento e lo sviluppo delle idee scientifiche.
Partendo dal medioevo, l'astronomia di questo periodo comprende sia
la parte di computus, relativa allo studio dei corpi celesti e dei
loro movimenti, sia l'astrologia che studia gli influssi dei cieli sugli
eventi umani. Entrambe queste discipline hanno all'epoca valore di scienza:
astronomia ed astrologia costituiscono praticamente due sinonimi. Si hanno
figure come Guido Bonatti, astrologo di Guido da Montefeltro, Bartolomeo
da Parma e Cecco d'Ascoli che mettono la loro scienza al servizio dei politici
e degli ecclesiastici, che riconoscono e accettano il potere esercitato
dalle stelle sulle vicende umane. Nel Trecento la cattedra di Astrologia
è considerata una tra le più importanti, avendo tale materia
uno straordinario riflesso diretto negli studi medici.
Questo porta a fare alcune considerazioni: la prima riguarda l'elevato
numero di Lettori che insegnano Astronomia in questo periodo e la seconda
riguarda come i Lettori trecenteschi e quattrocenteschi non siano solo
Lettori di Astrologia, ma insegnino anche altre discipline, soprattutto
Medicina e Filosofia, a testimonianza del fatto che i limiti delle varie
scienze non sono ancora ben delineati e la parte astronomica è strettamente
correlata con le altre materie. A questo proposito vediamo anche il programma
ufficialmente istituito nel 1405, ma sicuramente seguito già precedentemente,
in cui si nota la connessione e l'interdisciplinarità tra astronomia,
astrologia, geometria e medicina (Tabella 3).
_______________________________________________________________________
Tabella 3
Possiamo notare, inoltre, come nel corso del Quattrocento vari la denominazione della cattedra che passa indifferentemente da Astrologia ad Astronomia secondo l'anno accademico. Per l'astrologia il Quattrocento è un secolo fiorente e ricco di docenti, molti dei quali stranieri. Dalle due carte geografiche (Figure 1 e 2), in cui sono state riportate le città e i paesi di origine di tutti i Lettori per avere un quadro generale della varietà delle loro provenienze, si può notare come studiosi da ogni parte d'Europa abbiano contribuito all'insegnamento astronomico a Bologna, ad ulteriore testimonianza dell'importanza della cattedra bolognese. Bologna, all'epoca, vanta un prestigio e una tradizione ineguagliati tra le città italiane e non solo nel campo universitario e nello studio delle scienze, ma in tutte le manifestazioni culturali e artistiche, derivante da un periodo di floridezza economica raramente in seguito raggiunto. Anche per questo motivo, nel 1496, viene a studiare a Bologna Niccolò Copernico, il quale ha come maestro il Lettore di Astronomia Domenico Maria Novara. E' stata senz'altro rilevante l'influenza su Copernico e sulle sue idee innovative sia delle teorie neoplatoniche di Novara, sia dell'ambiente culturale e accademico bolognese di questo periodo.
All'inizio del Cinquecento, con il progredire degli studi medici ed il loro progressivo disinteresse verso l'utilizzo dell'astrologia per le diagnosi e le cure, anche l'insegnamento universitario di Astronomia perde di importanza, non essendo più al sevizio della medicina: la lettura nel 1508 diventa solo festiva, anche se i professori che tengono tale insegnamento sono nomi noti come Giacomo Pietramellara e Ludovico Vitali. Nel 1571, alla morte di Lattanzio Benacci, la lettura di Astronomia viene addirittura soppressa e, nel 1569, viene istituita la cattedra "ad Mathematicam" in cui si leggono, con un ciclo triennale, la geometria di Euclide, la teoria dei Pianeti e l'Almagesto di Tolomeo. In questo periodo gli astronomi bolognesi, come quelli di tutta Europa, sono rivolti più ai problemi connessi con la riforma del calendario e con la cartografia, che alla discussione sulle idee innovatrici di Copernico. La tradizione calendariale e cartografica è consolidata dalle opere di Egnazio Danti e di Giovanni Antonio Magini, autore del famoso atlante Italia. All'interesse per la geografia è strettamente legato il calcolo di una lunga serie di Effemeridi, che iniziano ad essere pubblicate a Bologna da Nicolò Simi nel 1554, seguite da quelle per gli anni 1581-1630 di Magini.
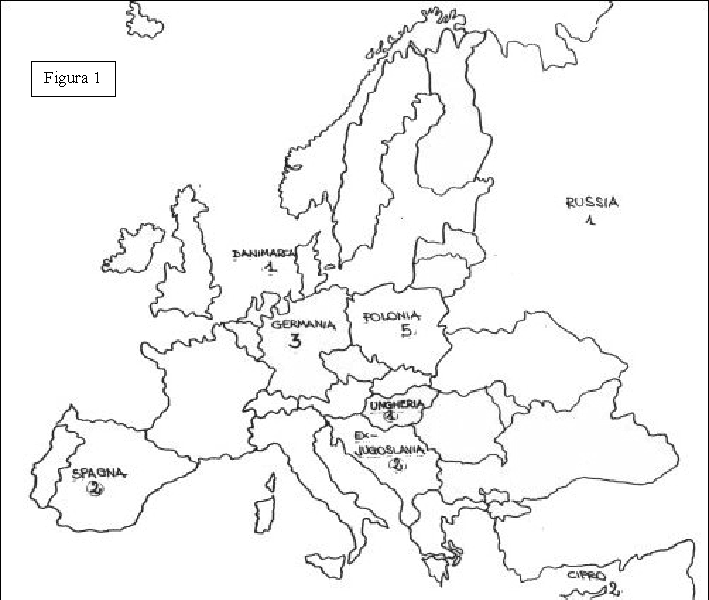
L'astronomia bolognese della prima metà del Seicento non presenta personalità di rilievo e l'ambiente scientifico viene dominato, non dall'Università, ma dalla scuola gesuita, in cui primeggiano due tra i maggiori astronomi del tempo, il ferrarese Giovanni Battista Riccioli e il bolognese Francesco Maria Grimaldi. Nella seconda metà del secolo, con le figure di Cassini e Montanari e con il crescere della sua importanza per le sempre maggiori ricadute di carattere geografico, l'astronomia locale, come quella europea, riprenderà nuova vita e diventerà una scienza di primario interesse e di vasta portata. Tale crescita è ampliata, nei primi anni del XVIII secolo, con la nascita dell'Istituto dell'Accademia delle Scienze e con la costruzione della Specola astronomica, la cui realizzazione e direzione è affidata a Eustachio Manfredi, figura di primo piano, di cui ricordiamo gli studi sull'aberrazione stellare, la compilazione delle Effemeridi Bolognesi e gli studi geografici e di idraulica. Nel 1737 viene di nuovo istituita una cattedra di Astronomia e viene variato il programma, per essere adeguato agli sviluppi moderni della scienza astronomica. Per inciso, si può sottolineare come ulteriori approfondimenti all'interno di questa ricerca possono essere dedicati allo studio dei programmi istituzionali d'insegnamento nel tempo ed al loro legame più o meno stretto con la cosiddetta ricerca "di punta".
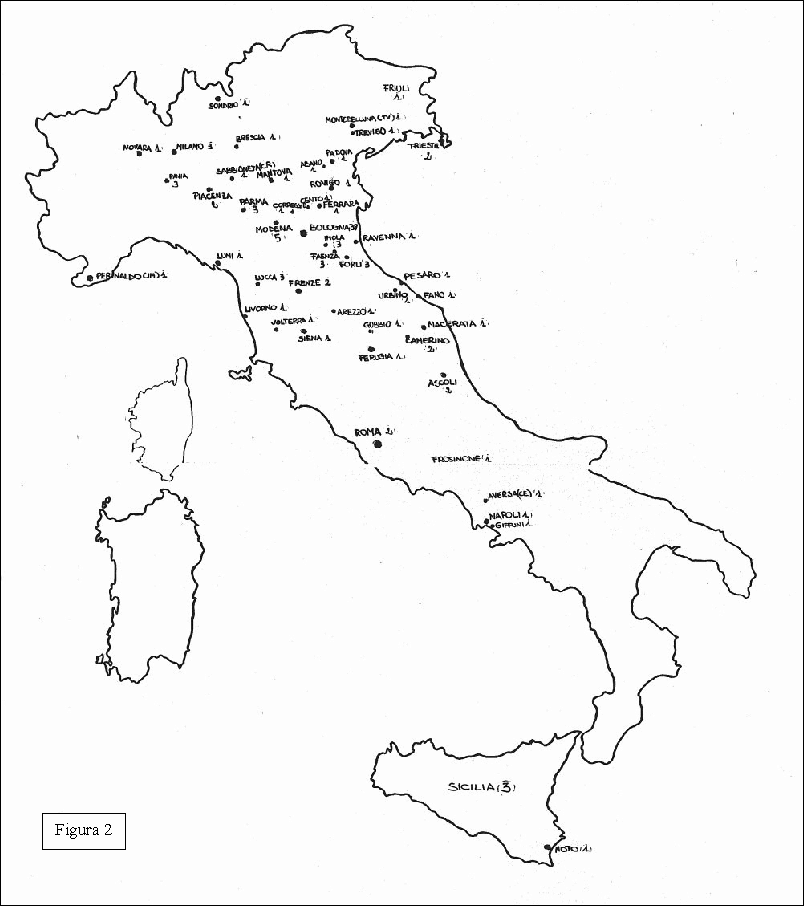
Proseguendo nell'esame delle biografie si possono percorrere anche i
secoli successivi, costatando come, nella seconda metà del Settecento,
abbia inizio un altro periodo di decadenza e di stasi degli studi astronomici,
che si protrarrà per tutto l'Ottocento, originato dai travagli della
regione legati, prima alle vicende delle repubbliche napoleoniche, poi
a quelle dello Stato della Chiesa ed infine all'istituzione del Regno d'Italia.
L'astronomia bolognese resterà così estranea al processo
che favorisce la nascita di una nuova disciplina, l'astronomia fisica,
nella quale l'Italia ha svolto un ruolo di primo piano.
Nella prima metà del Novecento, Guido Horn d'Arturo fa rifiorire
l'attività della Specola bolognese. Tra le sue varie iniziative
ricordiamo la costruzione del telescopio da 60 centimetri di Loiano, la
realizzazione originale di uno "specchio a tasselli", l'ampliamento della
biblioteca con l'acquisto di volumi antichi e recenti e la fondazione della
rivista di divulgazione astronomica Coelum. Infine, nel 1969, viene
istituito il Corso di Laurea in Astronomia e con la creazione della laurea
specifica gli studi astronomici subiscono un forte impulso e gli insegnamenti,
in precedenza afferenti al Corso di Laurea in Fisica, vengono ulteriormente
diversificati e specializzati.
Un ulteriore aspetto che meriterebbe di essere approfondito, soprattutto
per gli ultimi due secoli, riguarda l'esame delle vicende istituzionali
dell'astronomia nazionale, universitaria e no, e di come talune leggi abbiano
favorito o ritardato lo sviluppo della disciplina.
Non si vogliono trarre conclusioni dal lavoro svolto fino a questo punto,
del quale qui si sono presentati solo in accenno alcuni risultati preliminari.
L'intenzione, come espresso in precedenza, è che questo possa servire
come punto di inizio per ulteriori indagini che permettano, attraverso
uno studio che parta dalle biografie dei singoli Lettori di Astronomia,
di ampliare la conoscenza dello sviluppo dell'insegnamento e della ricerca
astronomica a Bologna.
Non era, inoltre, tra gli scopi di questa indagine esaurire il lavoro
di ricerca sulla valutazione dell'opera di ogni singolo docente, bensì
fornire indicazioni biografiche che possano essere uno strumento di lavoro
e uno stimolo a scoprire il contributo dato dai personaggi esaminati al
dibattito scientifico del loro secolo, a definirne il ruolo e, in alcuni
casi, a riconsiderarne l'opera, spesso sottovalutata se non ignorata, nel
più vasto contesto dell'Europa scientifica.
La storia della scienza in generale e dell'astronomia in particolare dipendono, infatti, da una storiografia scritta all'estero, per lo più nel mondo anglosassone, dove il contributo fornito da scienziati di altri paesi e di altre lingue è poco considerato.
Concludiamo, quindi, con una affermazione a questo riguardo di Umberto
Bottazzini, che ci trova pienamente consenzienti, tratta da una recensione
del volume "Science in the Twentieth Century" (J. Krige e D. Pestre, 1998):
"Vale la pena di sottolineare, e non certo per spirito nazionalistico,
che in quest'opera l'Italia brilla per la sua assenza. Non solo tra gli
autori di saggi (ad eccezione di Paolo Brenni) … anche tra i protagonisti
della scienza del nostro secolo i soli italiani che trovano un'occasionale
citazione sono Marconi, Fermi, Segrè e Natta. Tutto ciò deve
far riflettere sullo stato degli studi di storia della scienza nel nostro
paese".
Referenze bibliografiche
Trattandosi essenzialmente di un lavoro di ricerca bibliografica ed
archivistica, si sono consultate numerose fonti, ma non appare opportuno,
per semplici motivi di spazio, riportarle qui estesamente. Si rimanda,
comunque a due lavori che contengono riferimenti a tutte le fonti utilizzate:
Piliarvu D.; I lettori di Astronomia dello Studio Bolognese: 1125
- 1950, Tesi di Laurea in Astronomia, Università di Bologna,
1997.