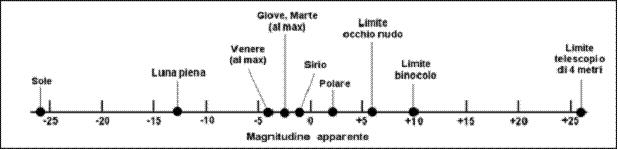|
|
|
|
|
|
|
|
|
La magnitudine stellare
Claudio
Elidoro
|
Anche un’occhiata
distratta al cielo stellato ci può permettere di verificare che non tutte le
stelle brillano con la medesima intensità. Non dobbiamo stupirci, dunque, se
il concetto di magnitudine stellare ci giunge fin dall’antichità. Già
nel secondo secolo a.C. il grande Ipparco di Nicea,
compilando il suo catalogo astronomico, introdusse una classificazione delle
stelle tenendo conto della loro brillantezza, classificazione che venne mantenuta anche da Tolomeo verso la fine del secondo
secolo d.C. La scala scelta dai due astronomi prevedeva che le stelle più
luminose venissero collocate nella prima classe, quelle un po’ meno
luminose nella seconda e, giù giù, fino a quelle
appena visibili a occhio nudo, collocate nella sesta classe. Erano tempi in
cui ancora non esisteva neppure il dubbio che le stelle potessero essere a
differenti distanze da noi, ma tutte venivano
considerate alla medesima distanza, fissate su quell’enorme
sfera che costituiva la volta celeste. Logico concludere, sotto questa
ipotesi, che una maggiore quantità di luce significasse anche una maggiore
dimensione. E così avvenne che lo stesso termine usato per identificare le
classi di Ipparco (magnitudo) sottolineasse proprio questa constatazione. Banale
sottolineare come si trattasse di una scala soggettiva e tutt’altro
che precisa, legata com’era all’acutezza visiva
dell’osservatore, alla sua capacità valutativa e alle condizioni
osservative. Fortunatamente erano tempi nei quali l’inquinamento
luminoso ancora non esisteva, ma è evidente che prima o poi sarebbe stato
indispensabile dare alla classificazione una connotazione più scientifica. Ci
provò inizialmente William Herschel (1738 – 1822), annotando come una
stella di prima magnitudine fosse circa 100 volte più brillante di una di
sesta, ma la soluzione definitiva fu opera di Norman
Robert Pogson (1829
– 1891). Utilizzando un primitivo fotometro ebbe la conferma di quanto
Herschel aveva segnalato e questo lo indusse nel La
risposta dell’occhio umano agli stimoli luminosi, però, non è di tipo
lineare. Negli stessi anni in cui Pogson avanzava
la sua proposta, Fechner e Weber dimostrarono che
nella percezione visiva la sensazione era proporzionale al logaritmo dello
stimolo. Questo, applicato al caso delle stelle, significava che la
magnitudine era proporzionale al logaritmo dell’illuminamento, vale a
dire:
Fissata
dunque una stella di riferimento caratterizzata da illuminamento Io
e magnitudine mo si poteva definire la magnitudine di
un’altra stella caratterizzata da illuminamento I come:
Applicando
alla (2) la convenzione proposta da Pogson si
determina il valore di k ottenendo:
L’espressione
(3) è dunque nota come Formula di Pogson e descrive
il legame tra la magnitudine di una stella e il flusso luminoso che giunge al nostro occhi. Ci
sono un paio di aspetti poco felici nella scelta di Pogson
di fare in modo di restare fedele alla classificazione di Ipparco.
Il primo è che, contrariamente a quanto il senso comune potrebbe suggerire,
la luminosità maggiore corrisponde a numeri più bassi, con la spiacevole
conseguenza che per il profano alcuni diagrammi in
cui compaiono le magnitudini non sono di immediata lettura. Un secondo
aspetto è che per oggetti particolarmente luminosi si è costretti a ricorrere
ai numeri negativi. Sirio, per esempio, ha una magnitudine di – 1.4 mentre per il Sole si deve raggiungere il valore di
– 26.74. Nella
fig. 1 sono riportati i
valori di magnitudine di alcuni corpi celesti. È un grafico indicativo ed
estremamente semplificato, ma è certamente in grado di dare un’idea
dell’estensione di questa scala.
Si
è già sottolineato che per gli antichi non si poneva il problema della
distanza di una stella. Per noi non è più così: sappiamo
infatti che le stelle non sono a uguale distanza da noi e questa
semplice constatazione ci impone una riflessione. La magnitudine che noi
rileviamo non dà alcuna informazione sulla effettiva quantità di luce
irradiata da una stella, ma si limita ad indicare che al nostro occhio giunge
più (o meno) energia luminosa che non da un’altra. Non siamo in grado,
cioè, di distinguere se la stella più luminosa emette maggiore flusso luminoso
o è semplicemente più vicina. Per questo motivo ci si riferisce alle
magnitudini definite da Pogson con il termine di magnitudini apparenti, intendendo con
questo aggettivo il fatto che le luminosità considerate sono quelle che
appaiono agli occhi dell’osservatore. E’
dunque necessario definire una nuova grandezza che dia
una corretta misura del rilascio di energia luminosa di una stella,
svincolandola dagli effetti della distanza. Questa grandezza è la magnitudine assoluta (M), definita
come la magnitudine che la stella avrebbe se venisse
osservata da una distanza fissata (arbitrariamente) in 10 parsec (32.6 anni
luce). L’espressione
che lega tra loro la magnitudine apparente (m), quella assoluta (M) e la
distanza (d) espressa in parsec è la seguente:
Per
ovvie ragioni di spazio il nostro discorso deve concludersi qui, ma è
inevitabilmente destinato a riaffacciarsi su queste pagine per affrontare
alcuni temi fino ad ora lasciati in disparte. Non è stato detto, ad esempio,
a cosa possa praticamente servire la relazione (4).
Non è stato fatto nessun accenno alla diversità di colore che caratterizza le
stelle e al suo possibile significato fisico. Abbiamo inoltre parlato di
magnitudini riferendoci esclusivamente alla rilevazione della luce visibile,
ma non è detto che tutta l’emissione di una stella cada necessariamente
in quella regione dello spettro elettromagnetico. Temi cruciali, come si può
ben intuire, e che sarà dunque necessario approfondire.
|