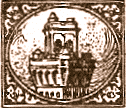
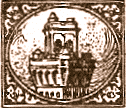
|
Museo della SpecolaSTRUMENTI DI LUSVERG |
Eustachio Manfredi commissionò gli strumenti per la Specola marsiliana al laboratorio di Lusverg nel 1702. Giacomo Lusverg, artefice di grande abilità morì nello steso anno ed il lavoro passò a suo nipote, meno esperto, Domenico.
Il primo dei due quadranti mobili di questa sala
fu costruito sotto la supervisione dell'astronomo parigino
Maraldi - a Roma per
molti mesi nel 1702 - sul modello degli strumenti parigini.
Da una lettera di Maraldi a Manfredi
in data 25 luglio 1702
apprendiamo, infatti, che Maraldi stava seguendo a Roma la fabbricazione dello
strumento, inducendo l'artefice a seguire tutte le
precauzioni necessarie per conseguire un risultato che
eguagliasse quello dei quadranti costruiti a Parigi e che
Picard aveva impiegato per la
triangolazione della Francia. Risultato che non fu
pienamente conseguito con questo strumento la cui
graduazione risultò alquanto irregolare.
Nonostante l'insuccesso del primo strumento, la fiducia di Manfredi in
Domenico Lusverg non venne meno e gli fu commissionato
un secondo strumento. L'artefice, lasciato questa volta
libero di procedere secondo il suo intuito, realizzò un vero
capolavoro, che per precisione e nitidezza dell'incisione
della scala non lasciava niente a desiderare ed in pratica
sostituì il primo quadrante. Secondo la richiesta di
Manfredi il lembo è
leggermente più lungo di 90 gradi, per poter impiegare il metodo
di verifica dello strumento, consistente nel rovesciarlo,
utilizzato dagli astronomi francesi.
I tratti incisi sul lembo non avevano errori maggiori
di un centesimo di millimetro e con questo strumento
Manfredi cominciò ad usare
il metodo delle altezze corrispondenti per ottenere il tempo
di passaggio degli astri in meridiano, raggiungendo una
precisione tale per cui scarti superiori ai due secondi
d'arco sono rari; il quadrante poteva quindi servire di
confronto sia per la regolarità di marcia degli orologi, sia
per il controllo della precisione del semicircolo murale.
Fu modificato da Manfredi nel 1728 con l'aggiunta di un secondo cannocchiale fisso perpendicolare a quello originario e nella struttura del piede, portato da 4 a 3 appoggi, per diminuirne l'ingombro e permettere di effettuare osservazioni mediante la fessura che attraversava il tetto della Stanza Meridiana.
Lo strumento di Lusverg, pur con dimensioni relativamente ridotte rispetto a strumenti coevi in uso negli osservatori di Londra e Parigi, non era ad essi inferiore per accuratezza. La latitudine di Bologna, determinata con il suo ausilio nel 1706, differisce dal valore vero di soli 8 decimi di secondo d'arco, un errore tipico per gli strumenti prodotti dall'officina dei Lusverg che li rende tra i migliori della prima metà del XVIII secolo.
L'uso di strumenti murali forniti di mire a cannocchiale risale al 1683, quando un primo strumento di questo tipo venne istallato all'Osservatorio di Parigi. Nel 1704, quando il nostro strumento fu realizzato e cominciò ad essere impiegato nell'Osservatorio Marsiliano, si trattava quindi di una procedura osservativa ancora abbastanza recente. Essa era stata resa possibile dai grandi progressi fatti in quegli anni dagli orologi, la cui marcia era diventata così accurata da mettere in competizione la precisione con la quale si poteva determinare la distanza tra due astri in base alla differenza tra i loro tempi di passaggio al meridiano, con la misura diretta ottenuta con i cosiddetti sestanti astronomici.
Fu con questo strumento che nel 1731 Manfredi fu in grado di confermare per primo la teoria di Bradley dell'aberrazione della luce e con essa l'evidenza, inaspettatamente trovata, della realtà del moto orbitale della Terra attorno al Sole, previsto nel sistema di Copernico.
Fu collocato in stazione nell'Osservatorio Marsiliano il primo agosto 1705 e rimosso il 28 maggio 1709
Il restauro è stato eseguito da Giovanni Morigi (Bologna) nel 1979.